
Concessioni – piano economico finanziario – art. 182, 185, 193 d.lgs. n. 36/2023 – documenti di gara e relativi allegati – PEF – predisposizione soggetto concedente – componente eventuale – funzione del modello di PEF – ausilio concorrenti
Consiglio di Stato, sez. v, 13 giugno 2025, n. 5196
La concessione, che rappresenta una species del più ampio genus delle forme di parternariato pubblico privato, si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario, pertanto, il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità, con riferimento agli operatori economici che partecipano alla gara, deve essere valutata dall’amministrazione.
La funzione primaria del PEF, dunque, è quella di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa concessa, che si concretizza nella contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.
Nel modello di PEF – eventualmente previsto nella documentazione di gara – l’amministrazione è tenuta a specificare gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere; infatti, se l’operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente inattendibile. In sostanza, gli atti a base di gara devono identificare le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l’onere economico, in modo da consentire di definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso della durata del rapporto, sull’equilibrio economico finanziario del servizio.
Indice
Il caso di specie
Una società pubblica indiceva una procedura (aperta) telematica per l’affidamento, in regime di concessione, per la durata di cinque anni, dei servizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, ristorazione e catering presso l’area del Parco del Foro Italico in Roma.
La procedura, strutturata in un unico lotto, si riferiva alle attività e processi relativi alle manifestazioni ed eventi organizzati presso detta area e lo stadio Olimpico.
Nel disciplinare veniva indicato il valore della concessione. L’offerta degli operatori avrebbe dovuto essere formulata prevedendo – quale prestazione in favore del concedente – un rialzo unico percentuale rispetto ai corrispettivi minimi garantiti (calcolati in un funzione di ciascun anno di durata della concessione) in favore dell’amministrazione.
In aggiunta agli importi minimi garantiti, in base alla lex di gara, l’affidatario della concessione avrebbe dovuto riconoscere alla P.A. concedente una quota pari al 25% del fatturato complessivo per la sola parte eccedente il citato minimo garantito (al netto dell’IVA dovuta), a cui aggiungere anche una royalty pari al 20% sul fatturato relativo al solo servizio di catering svolto in occasione di eventi organizzati da soggetti terzi.
In pendenza del termine per la ricezione delle offerte, giungeva un ricorso avverso la procedura, proposto dal concessionario uscente, titolare da oltre dieci anni del servizio di somministrazione di cibi e bevande nei punti di ristoro dell’aera del Parco del Foro Italico e dei bar aperti duranti gli eventi dello stadio Olimpico.
Con il ricorso introduttivo, la società contestava le previsioni e le clausole della lex specialis e, in particolare, i costi e i ricavi indicati nel PEF, i quali, a suo dire, le avrebbero impedito la partecipazione alla gara per l’assenza di condizioni di equilibrio economico finanziario.
Nello specifico, sulla base di una relazione predisposta da un consulente, lamentava l’insostenibilità del piano, facendo riferimento a tre aspetti: a) la sovrastima dei ricavi indicati nel documento (dovuta ad una asserita errata individuazione della spesa media per spettatore sia nel valore di partenza che nella proiezione temporale); b) la sottostima dei costi indicati dal soggetto concedente, con particolare riferimento ai costi del personale, non essendosi tenuto conto dei costi del personale e supporto specifico degli eventi, ma solo di quello stabile; c) il livello eccessivo del minimo garantito indicato nella lex specialis e l’impossibilità di farvi fronte sulla base dei ricavi attesi.
Inoltre, quanto al capitolato, evidenziava pure l’assunta genericità degli investimenti richiesti, stimati in circa 2.500.000 euro (aspetto che, a detta della parte, avrebbe impedito di valutarne la sostenibilità e i ritorni), e il trasferimento di rischi non controllabili al concessionario (nello specifico, quello per eventuali danneggiamenti/atti di vandalismo), oltre alla ritenuta circostanza che molti costi sarebbero stati “ribaltati” sullo stesso (ad esempio, per la gestione rifiuti e altro).
L’ABC degli appalti di forniture e servizi
I fondamentali per la corretta gestione operativa di tutte le fasi dell’appalto (D.Lgs. n. 36/2023, Decreto correttivo – D.Lgs. n. 209/2024 e Decreto Infrastrutture – D.L. n. 73/2025) Qualificazione stazioni appaltanti Il corso (di 20 ore) è stato accreditato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione nella categoria formazione “base” con Decreto del Presidente SNA n.100/2025
24 Set 2025 – 22 Ott 2025 ore 9.00-13.00
1,464.00 €
La decisione del TAR
Il TAR, all’esito del giudizio, respingeva il ricorso. Con riferimento alle doglianze indicate nel paragrafo precedente, in merito al valore della concessione, il TAR chiariva, innanzitutto, come il quantum indicato nella lex specialis fosse stato calcolato prendendo a riferimento il dato economico (fatturato) dichiarato dal gestore uscente (anno 2023), poi moltiplicato per gli anni di (prevista) durata della concessione (e cioè cinque anni).
Per il giudice di primo grado, la società concedente avrebbe addirittura mantenuto un atteggiamento di prudenza nel calcolo dei presunti ricavi, non essendo state considerate le partite che le squadre di calcio della Capitale (A.S. Roma e S.S. Lazio) avrebbero potuto disputare nelle competizioni internazionali negli anni a venire considerati nella concessione (Conference League, Europa League, Champions League), quelle eventualmente in Coppa Italia (a seguito del passaggio del primo turno) e la reale affluenza media di spettatori per ogni evento calcistico.
Riguardo l’assunta sottostima del personale da impiegare nella gestione della concessione, la ricorrente riteneva che la lex specialis avesse indicato, in atti, solamente gli oneri per il personale “stabile”, non per quello c.d. a chiamata in ragione dei singoli eventi, circostanza che avrebbe comportato una (supposta) sottostima del costo del lavoro (determinando – secondo l’operatore – l’oggettiva impossibilità di formulare un’offerta economicamente sostenibile). Il TAR, nel rigettare la doglianza, chiariva innanzitutto che l’elenco del personale contrattualizzato del gestore uscente (indicato negli atti a base di gara) evidenziava costi complessivi (per retribuzioni annue lorde) di circa 750.000 euro.
Ebbene, per il giudice, nel PEF disposto dall’amministrazione concedente, il costo del personale sarebbe stato rappresentato ad un livello superiore a quello sostenuto per il solo personale stabile (circa il doppio per ogni anno di concessione), con la conseguenza che, di fatto, essendovi stata una evidente sovrastima effettuata nel PEF per i costi di detto personale (quello stabile), ciò avrebbe sicuramente consentito di formulare un’offerta adeguata, dato che, proprio nella differenza tra quanto indicato nel PEF e costi sostenuti dal gestore uscente per il personale stabile, si sarebbero potuti far rientrare quelli del personale c.d. “variabile”.
Inoltre, sempre sul tema, il giudice rilevava una sostanziale congruenza tra quanto dichiarato dal gestore uscente in termini di incidenza dei costi complessivi del personale – compreso quello a chiamata – e costi del lavoro indicati nel PEF posto a base di gara. Di conseguenza, la concessione, avendo preso atto di questi dati: “…risulterebbe, comunque, in equilibrio economico-finanziario […], cioè vi sarebbe, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, pur sempre un margine di utile per il concessionario, aspetto che conferma come non vi fosse alcuna oggettiva impossibilità di formulare un’offerta economicamente sostenibile” (tanto è vero che diversi operatori avevano deciso di partecipare alla gara).
Infine, in merito al presunto eccessivo valore del “minimo” garantito (e cioè della somma indicata nella legge di gara – in relazione alla quale effettuare la propria offerta a rialzo – da garantire all’amministrazione concedente per ciascun anno di contratto), il TAR, nel respingere la censura, rilevava come le somme indicate in sede di disciplinare fossero state calcolate in funzione degli importi corrisposti dal gestore uscente per l’anno 2023 e del fatturato conseguito dalla ricorrente nello stesso anno (come da comunicazione dell’azienda resa ai fini della determinazione della percentuale di fatturato spettante alla concedente), nonché in ragione delle previsioni di crescita del fatturato (per gli anni a venire) stimate dallo stesso gestore uscente.
Pure tale ragione di doglianza, in definitiva, è apparsa infondata.
La decisione del Consiglio di Stato
Anche il Consiglio di Stato non ha accolto le tesi della ricorrente, formulate quali altrettante ragioni di critica avverso la decisione di primo grado.
Tenuto conto che, sostanzialmente, le contestazioni hanno avuto quale riferimento l’asserita insostenibilità del PEF redatto dalla società concedente, il giudice – al di là dei profili attinenti il merito della controversia su cui è stata confermata la decisione TAR – ha illustrato una serie di principi interessanti proprio riguardo la natura e la funzione del piano economico finanziario, intorno al quale ruota l’intera disciplina del partenariato pubblico-privato e, segnatamente, delle concessioni.
Il giudice ha avviato la sua indagine dal dato normativo. L’art. 182 Codice 2023, in particolare, dispone: “I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell’istituto finanziatore” (comma 5). L’art. 185, comma 5, invece, detta la disciplina sui criteri di aggiudicazione: “Prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario”.
Fatta tale premessa, il Consiglio di Stato è correttamente passato alla ricostruzione del ruolo del PEF nell’architettura del regime concessorio, sistema che, come noto, si atteggia diversamente – sotto il profilo della ripartizione del rischio operativo – rispetto a quanto risultante dalla disciplina in tema d’appalto. Infatti: “…La concessione, che rappresenta una species del più ampio genus delle forme di parternariato pubblico privato, si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario, pertanto, il PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità con riferimento agli operatori economici che partecipano alla gara deve essere valutata dall’amministrazione”.
Tale rischio, assunto dal concessionario, è interno, secondo il Consiglio di Stato, alla aleatorietà della domanda di prestazioni. Dunque, l’errore di valutazione del livello di “domanda attendibile” (da parte dell’utenza) condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica: “…si tratta, come noto, di una tipologia di rischio imprenditoriale diversa da quella riscontrabile nel contratto di appalto (di lavori, servizi, forniture), proprio perché entra in giuoco un elemento imponderabile (cioè la domanda di prestazioni per quel servizio pubblico), non determinabile a priori; elemento che nell’appalto non compare”.
In questo quadro, allora, funzione primaria del PEF è quella di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa concessa, che si concretizza nella contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, e rappresenta lo strumento attraverso il quale (come appena rilevato) si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti coinvolte.
Nel modello di PEF eventualmente predisposto dall’amministrazione (e posto tra gli atti di gara), la P.A. è tenuta, allora, a specificare gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere; infatti, ha chiarito il Collegio: “…se l’operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente inattendibile (Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2022, n. 2809)”.
Invece, quanto al dovere – da parte del soggetto concedente – di predisporre un “modello” di PEF (sulla cui base, evidentemente, gli operatori saranno chiamati ad esprimere le loro proposte con la redazione di un proprio piano unitamente all’offerta), il giudice ha chiarito che: “…la più recente giurisprudenza, sulla base di una lettura restrittiva delle disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023, ha in qualche modo attribuito al PEF una funzione meramente eventuale”. Secondo tale orientamento, riportato dal Collegio, l’art. 182 d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: “…l’affidamento delle concessioni deve avvenire tramite pubblicazione di un apposito bando, specificando al comma 5, che il PEF è una componente meramente eventuale” (si cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, 6 agosto 2024, n. 982; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11 luglio 2024, n. 2132). Il modello di PEF e, quindi, anche la valutazione (effettuata nel documento dalla P.A.) del fatto che l’operatore economico possa essere in grado di gestire il rischio operativo e di garantire la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico, costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, non suscettibile di censura da parte del giudice amministrativo, se non nei limiti (tipici di questa discrezionalità) di manifesta irragionevolezza ed errore macroscopico e manifesto.
La tesi più generale, secondo il giudice, emersa dai primi interventi interpretativi della giurisprudenza di settore, è che il legislatore non avrebbe inteso imporre un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni (questo vale tanto per la P.A. che per gli operatori economici), ma avrebbe lasciato spazio alla flessibilità e a una valutazione discrezionale da effettuarsi caso per caso, in funzione delle caratteristiche peculiari della concessione a gara.
In ogni caso, il PEF, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richieda. Il documento, da presentarsi in sede di offerta, andrà allora modulato (dall’operatore che intende competere per l’affidamento) in virtù delle caratteristiche del contratto cui accede.
Infine, secondo l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, la natura facoltativa del PEF verrebbe ulteriormente confermata dall’art. 193 Codice che, diversamente, impone espressamente la presentazione di un piano asseverato solo nell’ambito delle proposte di finanza di progetto, a carico degli operatori che intendono sottoporre alla P.A., quali promotori, le rispettive proposte.
Da ciò – secondo il Consiglio di Stato – ne deriverebbe la tesi per cui il legislatore avrebbe inteso come “essenziale” la predisposizione del PEF soltanto laddove la complessità e l’entità del progetto richiedano una valutazione più approfondita della sostenibilità economica e finanziaria.
Considerazioni conclusive: ancora sul PEF
In generale, nelle gare per l’affidamento di concessioni (di servizi, beni, lavori), l’amministrazione deve valutare la possibilità che il rapporto possa essere gestito in condizioni di equilibrio economico finanziario.
Dunque, deve esservi innanzitutto (al netto del trasferimento del rischio operativo ai sensi dell’art. 177 Codice) convenienza economica e sostenibilità finanziaria per il concessionario che dovrà gestire il contratto. Per convenienza economica si intende – in concreto – la capacità del progetto di creare valore durante il termine di efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato in virtù del capitale investito; invece, per sostenibilità finanziaria si indica la capacità dell’iniziativa di generare, nel tempo, flussi di cassa sufficienti a realizzare profitti, garantendo la continuità operativa della concessione e la possibilità, per l’impresa, di far fronte agli impegni finanziari assunti.
Tali elementi (convenienza economica e sostenibilità finanziaria) servono a valutare (dal lato dell’ente concedente) la fattibilità preliminare dell’intervento e la possibilità di stabilire anche un prezzo (consistente in un contributo pubblico) a compensazione di eventuali condizioni di disequilibrio fisiologico.
L’equilibrio economico-finanziario sussisterà, allora, quando i ricavi attesi del progetto saranno in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio (art. 177, comma 5 Codice).
In base a tali principi, il PEF, dunque, dovrà indicare la corretta allocazione dei rischi e contenere tutti i dati per la formulazione di un’offerta completa, consapevole e seria.
Quest’ultima (presentata dagli operatori economici) dovrà consentire alle stazioni appaltanti di valutare le condizioni di equilibrio economico finanziario definitive e contenere, pertanto, il progetto di gestione del servizio (o altro), nonché la sua traduzione in termini contabili effettivi.
Le informazioni contenute nell’eventuale PEF di gara (con le relative quantificazioni) risulteranno, pertanto, puramente indicative, ricadendo sugli offerenti l’onere di allegazione di un PEF, per la concessione cui ambiscono, in grado di fotografare le condizioni di equilibrio definitive (fermo restando che, come è stato evidenziato, non è sempre necessario richiedere nel bando, per l’affidamento di una concessione, la previa presentazione di un PEF ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’offerta economica: si cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2021, n. 5283; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 11 luglio 2024, n. 2132).
Fattore determinante nella definizione del PEF è il trasferimento del rischio operativo (tipico delle concessioni), il quale provoca, a carico dell’affidatario, la traslazione dei rischi connessi alla domanda (vale a dire il rischio legato ai diversi volumi di richiesta, ad esempio, del servizio che il concessionario deve soddisfare, oppure il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa) e/o alla disponibilità (o dell’offerta) dell’attività oggetto di concessione (vale a dire alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti) (si cfr. TAR Toscana, Firenze, II, 17 ottobre 2023 n. 941).
Il rischio assunto dal concessionario si valuta proprio intorno alla aleatorietà della domanda di prestazioni, poiché l’errore di valutazione in tal senso, evidentemente, condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica. Si tratta, come noto, di una tipologia di rischio imprenditoriale diversa da quella riscontrabile nel contratto di appalto (di lavori, servizi o forniture), proprio perché entra in gioco un elemento imponderabile (e cioè, ad esempio, la domanda di prestazioni per quel servizio pubblico, non determinabile a priori); elemento che nell’appalto non compare (in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2025, n. 3633).
È fisiologico, tuttavia, che, nella dinamica giuridica ed economica delle concessioni, non ogni famiglia di rischio venga trasferita in capo al concessionario. L’obbligo imposto dalla legge è quello di una sostanziale traslazione del rischio operativo e il divieto di un intervento pubblico volto a sanare carenze o inadempienze gestionali comunemente connesse al rischio di impresa.
Si considera assunto il rischio operativo da parte del concessionario quando, in condizioni operative normali: “…non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario” (art. 177, comma 2 d.lgs. n. 36/2023).
Naturalmente, se è vero che lo strumento concessorio si connota per la traslazione, dall’ente pubblico concedente al soggetto privato concessionario, del rischio economico derivante dalla gestione di un bene, un servizio, ecc. avente attitudine produttiva, è del pari incontestabile che l’operatore non potrà essere esposto a un’alea indeterminata, tale da alterare la naturale funzione commutativa del contratto.
Non è (e non sarà) in altri termini sostenibile che tutti i rischi contrattuali ricadano indiscriminatamente sul gestore privato (si pensi a eventuali responsabilità per carenze progettuali, che il privato partecipante alla procedura competitiva per l’aggiudicazione del contratto potrebbe, in piena buona fede, ignorare). Ad opinare in questo senso, infatti, verrebbe meno la stessa ragione di una procedura competitiva destinata al mercato, perché sarebbe impossibile o comunque inutile qualsiasi stima circa la convenienza economica del contratto, convenienza che costituisce la ragione fondamentale in forza della quale soggetti imprenditoriali concorrono per l’aggiudicazione di contratti pubblici (si cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4979; si v. pure TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 giugno 2015, n. 1316).
Fatte queste premesse, allora, se la concessione si qualifica per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario,il PEF è lo strumento mediante il quale:“…si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto, la cui adeguatezza e sostenibilità deve essere valutata dall’amministrazione concedente alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili e sulla base delle eventuali prescrizioni che la stessa amministrazione ha dettato con la lex specialis della procedura per la selezione del concessionario”; “…la funzione del PEF [è] quella di dimostrare la concreta capacità dell’operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni per l’intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico e finanziario di investimenti e connessa gestione che consenta all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione”; “…in altri termini, il PEF è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, quale dimostrazione che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività” (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795; si v. pure TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2025, n. 11824).
Come evidenziato dall’art. 192 Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento (purché non imputabile al concessionario), che incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, il concessionario potrà chiedere la revisione del contratto, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. L’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, dovuto a eventi diversi da quelli indicati – e rientranti nei rischi allocati alla parte privata – resterà, invece, a carico della stessa.
Naturalmente, l’ordinamento non garantisce il diritto a una revisione che riconosca le condizioni pretese dalla parte privata contraente. Impone l’onere in capo al concedente di avviare trattative sul punto. Trattative che l’amministrazione dovrà condurre – in buona fede – dovendo sempre avere ben presente, oltre all’ordine contrattuale civilistico, l’interesse pubblico da tutelare. La norma (art. 192, cit.) prevede la ricerca di un accordo; la sua mancanza legittimerà, invece, il recesso dal contratto.
La giurisprudenza, in merito alla revisione del contratto di concessione, ha chiarito che: “…non pare possibile individuare, nei principi di correttezza e buona fede oggettiva nell’interpretazione ed esecuzione dei contratti di durata (artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.), una base legale per fondare un obbligo di rinegoziazione di rapporti negoziali sperequati per il verificarsi di circostanze imprevedibili, nell’ipotesi di omessa definizione pattizia delle modalità di gestione delle sopravvenienze” (Cons. Stato, sez. VII, 24 luglio 2023, n. 7200; si consideri, ad esempio, che, a norma dell’art. 189 Codice, a differenza di quanto stabilito nell’art. 120, la previsione di clausole di revisione prezzi nelle concessioni – ex art. 60 Codice – è solo eventuale rispetto, invece, al loro doveroso inserimento nei contratti di appalto).
L’onere in capo alla pubblica amministrazione – vigente, in ogni caso, l’art. 9 Codice quale principio generale – è, pertanto, quello di avviare un percorso di revisione; non esiste, e non sarebbe compatibile con i principi generali della materia, invece, un diritto soggettivo (del concessionario) a ottenere la quantità di beneficio perseguito impedito dall’avvenuta alterazione dell’equilibrio economico finanziario, causato da un dato evento esterno.
Il percorso di revisione è, in altre parole, immaginato quale strumento, che la pubblica amministrazione non può evitare, di ricerca di un nuovo equilibrio tra le parti. L’evento imprevedibile, allora, è condizione necessaria – a far valere l’esistenza di un’alterazione delle originarie condizioni e dunque l’opportunità della ricerca di un componimento – ma non sufficiente a garantire il raggiungimento dell’intesa.
In definitiva, non è previsto, nella logica e nella lettera del legislatore, una sorta di diritto soggettivo in capo al contraente di ottenere (o meglio, riottenere) il profitto che le condizioni obiettive hanno reso non raggiungibile, tanto è vero che, come accennato, il comma 4 dell’art. 192 stabilisce, quale rimedio ultimo, quello del recesso dal contratto.
In tal caso, al concessionario dovranno essere attribuiti gli importi di cui all’art. 190, comma 4, lett. a) e b) Codice e cioè il valore delle opere realizzate/costi effettivamente sostenuti dal concessionario e i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.















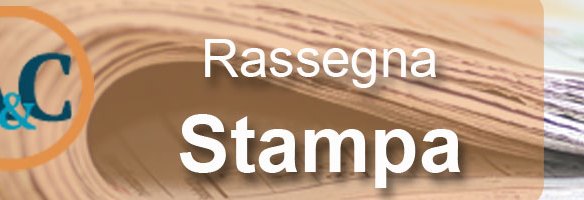



Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento