A proposito di compensazione prezzi nell’ambito dei lavori pubblici, la previsione di un meccanismo lato sensu indennitario della perdita economica subita dall’appaltatore a causa dell’aumento dei prezzi presuppone quindi necessariamente l’esigenza per l’amministrazione di proseguire nel contratto.
In tale logica non può trovare spazio la pretesa dell’appaltatore di vedersi remunerare, ex post, prestazioni relative a rapporti contrattuali ormai esauriti, che siano state eseguite con esito soddisfacente per l’amministrazione nella vigenza di diverse e meno convenienti condizioni economiche.
Il reciproco adempimento delle prestazioni, nei contratti commutativi, estingue le reciproche obbligazioni, sicché, in riferimento a queste ultime, non può più predicarsi la pretesa all’attivazione di vicende modificative.
È quanto stabilisce il TAR Lombardia – Brescia – con la sentenza della sez. II del 13/05/2025 n. 413.
I fatti in causa
La controversia giunta all’attenzione del giudice amministrativo si riferisce ad un appalto di lavori.
L’impresa esecutrice, pur avendo completato i lavori nel 2022 (nella sentenza si legge che <I lavori venivano completamente ultimati in data 29 novembre 2022 ed il successivo 28 novembre 2023 veniva rilasciato il certificato di collaudo, approvato dalla stazione appaltante con determinazione n. 231 del 31 gennaio 2024>), a gennaio 2025 aveva indirizzato all’amministrazione una istanza di compensazione prezzi relativamente agli incrementi verificatisi nel corso del primo semestre 2021 per i materiali oggetto di rettifica. In altri termini, la ricorrente chiedeva formalmente alla Stazione Appaltante di andare a rideterminare, con i nuovi valori stabiliti dal Ministero, le variazioni percentuali dei prezzi già riconosciuti, ai fini della liquidazione di quanto effettivamente spettante a titolo di compensazione.
L’istanza veniva rigettata dall’amministrazione per due ragioni: (a) tardività della domanda, in quanto presentata secondo la tesi dell’Amministrazione oltre il termine previsto dal D.M. specifico a cui l’impresa ricollegava la propria richiesta compensativa; (b) non spettanza di tale adeguamento, in quanto i lavori erano già stati conclusi e collaudati.
Contro la decisione l’appaltatore è insorto dinanzi al TAR che tuttavia ha respinto il ricorso sostenendo “sostanzialmente” la non operatività dell’istituto della compensazione a lavori terminati.
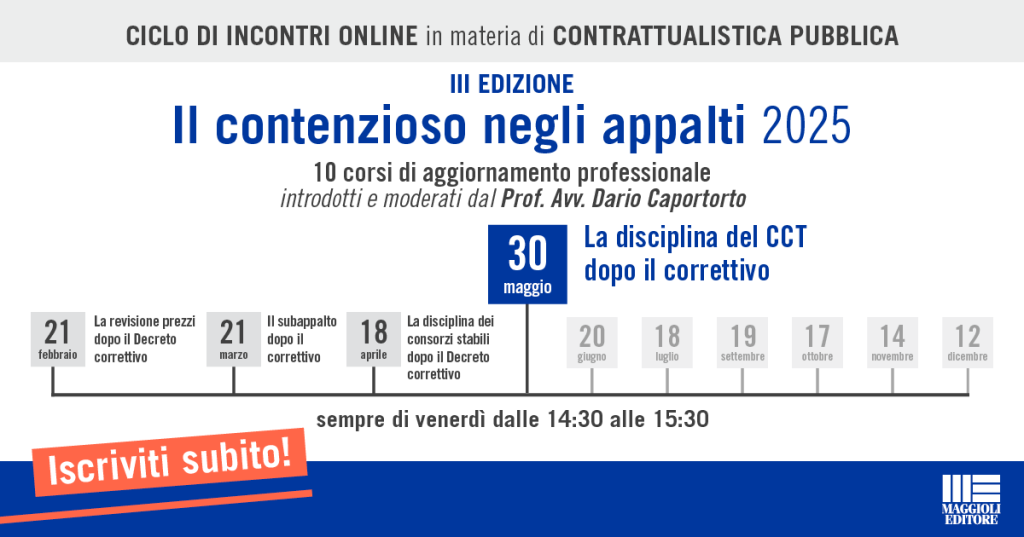
La decisione
La sentenza giunge alle sopra accennate conclusioni che certamente si prestano a valutazioni critiche, tuttavia sin da subito deve evidenziarsi il metodo di ragionamento scelto dal giudice amministrativo lombardo per rispondere alla questione giuridica posta: se sia possibile effettuare la compensazione prezzi prevista per i lavori pubblici da una specifica disciplina di legge ex post, cioè dopo che l’opera sia stata completata e collaudata.
La decisione del giudice amministrativo lombardo muove dal richiamo alla disciplina di diritto comune recata all’art. 1664 c.c., quest’ultima intesa a regolamentare il rapporto nei casi di sopravvenienze di fatto che incidono sul sinallagma contrattuale alterandone l’equilibrio giuridico-economico stabilito inizialmente dalle parti.
Il G.A. rammenta quindi che i contratti c.d. commutativi, come il contratto di appalto, sono retti dal principio di corrispettività fra prestazione e controprestazione (c.d. equilibrio sinallagmatico).
Tale equilibrio – spiega il Tar Lombardia – deve accompagnare il rapporto contrattuale per tutta la sua durata, distinguendosi tra sinallagma genetico (così identificandosi l’equilibrio delle prestazioni come individuato in sede di stipulazione del contratto) e sinallagma funzionale (ossia l’equilibrio che viene in rilievo nella fase esecutiva del contratto).
Nella disciplina in materia di contratti pubblici il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è oggi previsto dall’art. 9 del d.lgs. 36/2023 tra i principi generali riguardanti l’intera materia dei contratti pubblici, e trova attuazione negli artt. 60 e 120, che regolano la revisione dei prezzi e la modifica dei contratti in caso di eventi che incidano significativamente sull’equilibrio economico originario.
La sentenza ripercorre la ratio dell’istituto della revisione del prezzo; essa è quella di garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Allo stesso tempo, peraltro, l’istituto tutela anche l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante l’arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1337; Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2015, n. 1074; in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2011, n. 4362; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2010 n. 3019; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2010 n. 5954; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2007, n. 4679).
Sulla scorta di tali premesse tuttavia il giudice amministrativo spiega che il meccanismo revisionale non può risolversi in un automatismo che opera ad ogni variazione di costo.
Sempre la sentenza, compiendo un’opera ricognitiva della disciplina revisionale, poi rammenta che in epoca pandemica ed <ante codice> il legislatore ha introdotto alcune disposizioni per fronteggiare gli aumenti di costi causati dalla crisi epidemologica e dalla coeva crisi bellica <russo ucraina>, quali l’art. 1 septies del d.l. n. 73 del 2021, conv. in l. n. 106 del 2021, che ha previsto un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione maggiormente utilizzati.
Quanto a tali previsioni compensative, il G.A. spiega che le relative somme non costituiscono, tuttavia, un’integrazione del corrispettivo o una revisione del prezzo in senso stretto, in quanto non sono finalizzate a coprire interamente lo scarto tra il prezzo concordato e quello formatosi successivamente sul mercato, ma si limitano a consentire un adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio generato dalla sopravvenienza atipica. Per il Tar Lombardia si tratta dunque di un ristoro direttamente riconosciuto dal legislatore, e quantificato in maniera tassativa in forza di decreti ministeriali.
Proprio sulla ratio dell’istituto compensativo, la decisione in esame spiega che essa trova la sua ragion d’essere nella funzione di ripristino del sinallagma nei contratti di durata ancora in corso di esecuzione. Testualmente si legge nella sentenza <La compensazione si giustifica infatti perché vi è un interesse pubblico alla stabilità del rapporto e alla corretta esecuzione del contratto, che fa preferire al legislatore il rimedio manutentivo rispetto ai tipici rimedi caducatori (quali ad esempio la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta)>.
Mentre quanto al riparto di giurisdizione è altrettanto importante il punto di approdo a cui giunge la sentenza, in quanto sostiene che laddove viene in rilievo un meccanismo di revisione previsto dal legislatore, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In definitiva il G.A. con la sentenza in esame riconducendo il contratto di appalto nel genus dei contratti cc.dd. commutativi colloca l’istituto della compensazione prezzi, in quanto rimedio manutentivo ex lege, fuori dal contesto contrattuale in senso stretto, ricostruendo la sua ratio e distinguendo la fattispecie compensativa dalla fattispecie revisionale. Ma soprattutto delimitando il suo spazio temporale di operatività.


















Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento